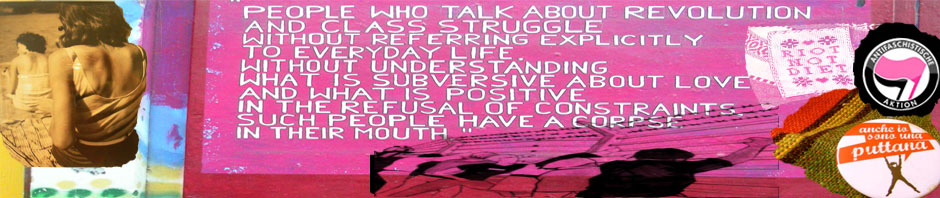Oggi niente sale sulla pelle. Il mare lo si vede all’orizzonte, sotto gli occhi libertà/liberazione.
E questo testo di carla lonzi.. la spietata. (o la scontrosa) 😉
“Mito della proposta culturale”, Carla Lonzi
Tratto da “La presenza dell’uomo nel femminismo” (1978) di C. Lonzi, M. Lonzi, A. Jaquinta, pp. 137-152
Incongruenza. Scrivere è un atto pubblico. Si scrive per esprimersi e per dare risonanza, perché un’altra possa esprimersi e dare risonanza. Ogni altro modo di scrivere è una manifestazione di inserimento culturale. Se non ci si riconosce l’una con l’altra chi è riconosciuto è l’uomo: viene così avvalorata la sua cultura.
E’ quello che trovo nel libro di Lea Melandri « L’infamia originaria facciamola finita col Cuore e la Politica”» (ed. Erba Voglio, 1977). La Melandri accenna al problema in modo indiretto confessando di provare «imbarazzo e sofferenza nel dovere sostenere la contraddizione di un lavoro individuale dentro una pratica comune con altre donne» (p. 7). Cioè a dire che è un problema prendere la parola in pubblico mentre le altre parlano solo in privato, e quindi possono sentirsi prevaricate. Ma formulato così il problema si rovescia in una captatio benevolentiae. Infatti il passaggio dal parlare allo scrivere è una presa di coscienza di sé che non può essere ritorto su chi l’ha fatto – a meno che non si tratti di un passaggio strumentale.
Quando alla Melandri si presenta l’occasione di dare riscontro a chi le ha offerto qualcosa di non anonimo da quel gruppo allargato che è il femminismo, tace, anzi nega. Perché non ne approfitta invece per diminuire l’imbarazzo e la sofferenza che dice di provare a farsi protagonista tra chi non lo è? L’occasione a cui mi riferisco è la distinzione tra una sessualità femminile e una sessualità imposta dall’uomo su cui la Melandri basa sostanzialmente le sue argomentazioni.
Questa distinzione risale esattamente a «Sessualità femminile e aborto» e «La donna clitoridea e la donna vaginale», cioè al ’71, anno in cui la Melandri dichiara di essersi avvicinata al femminismo: «Devo dire che fin dal primo impatto col femminismo nel ’71, quando ancora non si parlava di analisi del profondo, quando il problema era ancora quello di ricostruire la fisionomia sociale e politica della problematica legata al rapporto uomo-donna, già allora, a me personalmente, si affacciava l’esigenza di rileggere e ricostruire la mia storia sulla base della coscienza politica che acquistavo» (p. 122).
Al contrario già allora in me personalmente era accaduto di scrivere e di pubblicare un libretto sul sesso, frutto di una presa di coscienza che avevo fatto nel gruppo di Rivolta proprio a Milano, e che comunque non derivava dall’analisi del profondo.
Perché la Melandri non mi dà quello che mi spetta? Tra i motivi della sua perplessità a pubblicare la raccolta dei suoi scritti leggo: « ambizione malcelata di dire cose assolutamente originali » (p. 7). Ma io avevo detto qualcosa di originale, e questo la Melandri non può accettarlo poiché lei considera un successo proprio l’averci rinunciato. Al posto del bisogno rimane l’invidia e quindi l’annullamento dell’altra che non può, non deve esistere.
La Melandri non specifica cos’è questa sessualità femminile, la adombra in termini dotti «sessualità pregenitale» (perché pre-qualcos’altro? perché definirsi in rapporto all’altro?). Comunque può non avere a che fare con il capovolgimento tra vagina e clitoride, tra identità vaginale e identità clitoridea? No, non può. Nel ’71 ho scritto: il sesso femminile è la clitoride, la vagina è il luogo della colonizzazione maschile e della procreazione. La Melandri non ha idea cos’è affermare per la prima volta qualcosa del genere. Non ne ha idea perché non ne ha fatto esperienza.
Non chiama in causa una donna che è una: il suo dibattito si svolge tutto, pro e contro, con nome e cognome, in un ambito maschile. Prende in considerazione le obiezioni alla pratica dell’inconscio che possono venirle dal mondo politico, dai marxisti; non una parola sulle obiezioni che le vengono dal femminismo, da chi si è messa sulla strada dell’autocoscienza. Ma che razza di politica femminile è questa?
E potrei continuare: la Melandri non fa riferimento neppure a « Sputiamo su Hegel » (io parlo per me), sia nei punti dove concorda sia nel significato più generale di testo femminista che ha aperto una breccia nei ricatti marxisti verso le donne e nell’impostazione patriarcale della politica e della rivoluzione. Come ha potuto passarmi sopra? Perché affermare che nel ’71 i discorsi politici all’interno del femminismo erano «ancora abbastanza tradizionali » quando gli spunti di novità erano tali che non potevano essere accolti se non scardinando l’inserimento politico del ’68? Inserimento a cui la Melandri, con debito di riconoscenza tipicamente mal posto ma giustamente ammesso, si richiama: « Lo star tra donne nella fantasia si associava continuamente all’idea di essere fagocitata, strangolata dalla madre… come se l’esistenza, quel barlume di esistenza che credevo di aver trovato dopo il ’68, fosse ancora strettamente legato al mondo maschile. (Era cominciata allora la mia partecipazione alla rivista L’Erba Voglio) » (p. 123).
Perché questa leggerezza nel sorvolare sui momenti dell’espressione di altre da cui si traggono verifiche e conferme?
Oppure non si tratta tanto di verifiche e conferme quanto di supporti culturalmente intesi, mi sembra il caso della Melandri, per una sua tesi da sviluppare.
Così avverto l’incongruenza di risentirmi con lei, e nello stesso tempo non condividere il modo con cui collega la distinzione tra sessualità femminile e sessualità imposta (distinzione che per me ha valore solo in quanto riflette dati ricavati dall’autocoscienza) con l’interpretazione psicanalitica della Madre. Questa incongruenza è la spia di un mio vecchio problema: ho avvertito sempre una tale necessità di rispondenza per calmare il lavoro ininterrotto con cui cerca di mantenere fiducia nella mia espressione, che le impossibilità di un’altra mi colpivano prima di tutto come una privazione inferta a me stessa. Come un qualcosa (rispondenza) che mi veniva tolto e non come un qualcosa (coscienza di sé) che l’altra non era in grado di dare. Ma non potendo non mettere in relazione la non coscienza di sé con una dipendenza dall’uomo (cultura), finivo per sentire giustificata la mia aggressività, anche se in un secondo tempo provavo senso di colpa per avere reagito così a delle impossibilità altrui. E’ stato da questo tormento che poco a poco mi sono resa conto che non esiste una coscienza di sé senza un’altra coscienza di sé, e che questo si verifica nella rispondenza. Il senso di colpa racchiudeva la scoperta, avvenuta in seguito, che la mia via di uscita e quella dell’altra sono intrecciate. Il femminismo, cioè il gruppo, ha avuto per me questo contenuto.
Finora ho trovato conferme, indirette, in chi, per esempio la Solanas, si è espressa accettando l’urgenza e il rischio di una condizione solitaria, piuttosto che in chi ha potuto contare sulla pratica con altre donne in pieno femminismo come la Melandri, dalla quale mi divide prorprio l’avere in comune alcuni presupposti con un significato tanto diverso. La Solanas si è presa l’incomodo di odiare gli uomini, è da questo stress che le deriva la lucidità su di loro. Sebbene lontana dal suo odio, che nel passato ho spesso desiderato senza raggiungerlo come elemento risolutivo di dubbi e mezze verità, avvertirei la pavidità della storia di un’oppressione come la nostra senza la sua voce. Mi chiedo: perché l’operaio della Bovisa non deve sapere cosa è l’odio di una donna? Perché metterlo al riparo dall’espressione? Forse che in altri campi si usa riservare trattamenti soffici a chi deve prendere coscienza di prevaricare? Perché gli attacchi diretti vengono tenuti in sospeso finché non si sia trovato il modo di assestarli tra due citazioni di Marx? Perché avvicinare gli uomini come se fossero dei bambini a cui le proprie verità bisogna porgerle adottando il linguaggio dei loro libri di lettura? Perché questa serietà, questo accoramento? Per farli capire, cioè per non perdere l’aggancio culturale. Allora qual’è la pratica che fa deperire la Politica (e le maiuscole in genere)? Quella di « porre domande che disturbano il potere-sapere costituito », oppure di fare tutti i gesti di espressione di sé e di riconoscimento dell’altra che aprono le porte del limbo in cui le donne cercano, senza trovarla, un’incarnazione reale? Il blocco va forzato una per una: questo è il passaggio necessario per la nascita della propria individualità, il presupposto di qualsiasi cambiamento.
Ognuna di noi deve scontare dei miti, deve farlo per liberarsene. Ma deve accettare che le altre distinguano le aperture reali da quelle apparenti. Cito dall’« autobiografia politica » della Melandri ( « Per un’analisi della diversità », 1975) con cui termina il volume: «Anche perché io ho avuto un forte interesse intellettuale nel rapporto con l’uomo, ho sempre cercato rapporti in cui c’era creatività e possibilità di elaborare qualcosa insieme. Capivo che con le donne avrei dovuto creare qualcosa di altrettanto intenso sia affettivamente che intellettualmente per potermi staccare dall’uomo » (p. 125). E poi: «…avere esperienza analitica non è l’essere esperti; ma l’avere coscienza di ciò che si gioca a livello profondo e l’esserci abituati a farci attenzione» (p. 125). A me sembra che la Melandri abbia fatto un tiro a se stessa quando si è proposta di staccarsi dall’uomo attraverso rapporti altrettanto intensi con donne (perché staccarsi dall’uomo? non lo dice, in un ambito femminista le sembra scontato, ma non lo è: come dato personale allude all’angoscia dell’abbandono). Siccome non c’è riuscita, come dimostra il libro in questione, ha affermato solo di avere stretto rapporti intensi con donne e contemporaneamente realizzato il suo legame intellettuale con l’uomo.
Insomma mi meraviglia trovare nella Melandri così poca coscienza a proposito del suo rapporto con l’uomo, la cultura, la politica. Non so come potesse pensare di deviare un desiderio tanto radicato solo interpretando come mai è così radicato e prendendo provvedimenti sulla base di quella interpretazione. Cito ancora: « …dicevo: guardate che io sto male, vengo qua, ma stanotte ho avuto un incubo, sono stata malissimo, il pensiero di trovarmi solo fra donne mi ricostruisce dentro dei fantasmi di paura. Insistevo molto sulle resistenze che nascono nelle donne rispetto a una pratica che le vede separate dagli uomini. La scelta dell’autonomia mi convinceva immediatamente a livello politico, ma a livello profondo risvegliava dei timori » (p. 122).
La Melandri non ha nessun dubbio che ci fossero dei motivi di autenticità per stare male, e non l’essere solo fra donne; nessun dubbio che le resistenze fossero proporzionali a un suo momento particolare di rapporto con l’uomo; nessun dubbio che il livello politico a cui si trovava convinta fosse ancora un’ipotetica ideologia su di lei; nessun dubbio che i timori non manifestassero un qualche messaggio di conferma a livello inconscio.
Insomma, per la Melandri, stare male fra donne è frutto di resistenze dovute alla scelta dell’autonomia dall’uomo. Si può immaginare niente di più preordinato? Secondo la mia esperienza, si sta male fra donne quando questa scelta di autonomia è ambigua, quando l’uomo è presente, ma nascosto da una connivenza ideologica. Si comincia a stare bene fra donna quando il problema è ammesso, segno che il bisogno di autonomia non si presenta più come un dover essere, un dover dimostrare, ma come ricerca di sé e della coscienza di sé.
Al contrario l’impostazione della Melandri cancella ogni traccia personale del problema e rivela che la sua attenzione è volta non tanto a ciò che essa vive, quanto alla proposta culturale che ne può scaturire. E il destinatario di una proposta culturale, qualunque essa sia, è l’uomo. Ognuna elabora un tipo di proposta culturale per l’uomo che ha in mente poiché ognuna porta nel femminismo una sua fede culturale, se non l’ha in qualche modo consumata vivendola. Avendola vissuta in modo da consumarla. L’autocoscienza non è una proposta culturale. Ma non è neppure affastellare storie su storie come sembra intenderla la Melandri. Perché non si riferisce a un testo che esiste e si chiama appunto « Autocoscienza » di Alice Martinelli? E’ del ’75, anno in cui la Melandri scriveva la sua « autobiografia politica »: la differenza salta subito agli occhi. La Martinelli punta all’accettazione di sé, la Melandri giustifica il suo non riuscire a accettarsi, la giustificazione è offerta da una teoria.
La tesi della Melandri sulla Madre come primo oggetto d’amore, proprio per la sua ambizione a diventare una tesi chiave dell’identità femminile invece che una tappa di autocoscienza, funziona da schermo rispetto al nodo dell’identità: cacciato dalla porta, il problema rispunta dalla finestra come obiettivo culturale. Infatti la Melandri non si esprime: racconta di sé, si interpreta, quindi è ancora prigioniera di una soggezione che le impedisce di uscire allo scoperto. Soggezione a chi? Lei chi è?
Io non ho teorie da contrapporre, posso solo dire che questa formulazione della Madre esprime la censura tipica delle donne che finora hanno solidarizzato a condizione di negare reciprocamente, razionalizzando, la propria meta nell’uomo. Il femminismo ha ereditato questo presupposto dalla realtà dei rapporti fra donne.
Nessuna Risposta. Questo dirottamento dei rapporti, nei gruppi femministi, verso l’analisi del profondo o pratica dell’inconscio non mi va per diversi motivi, ma soprattutto perché si ha un bel dire che non esiste più analista né analizzata, c’è circolarità, ecc. Non è vero: esiste la cultura dell’analisi. Ossia: quello che viene detto sprofonda e resta solo quello che, come teoria, viene elaborato.
Mi ha sempre colpito come caratteristica di un rapporto istituzionale il fatto che né la chiesa né la psicanalisi avessero saputo che farsene di quel momento di contatto individuale rappresentato dalla pratica del confessionale e del lettino. La cultura del peccato e della malattia mentale era lì per distruggere l’espressione di un vissuto che traboccava sotto spinte incontenibili di sofferenza. Se penso a momenti in cui la delusione umana può avere toccato i vertici mi vengono in mente questi due tipi di confessione.
Se uno si rivolge alle istituzioni vuol dire che nella sua vita privata è arrivato a un’impasse nella comunicazione, che nessuno dei rapporti che si è creato riesce a soddisfare il suo bisogno di rispondenza. Questo bisogno non può essere soddisfatto neppure dalle istituzioni che però, in quanto tali, sanno come trattare un individuo che è arrivato a tali estremi. L’una promette di ridargli la pace liberandolo dal peccato, l’altra dalla malattia mentale. Da allora quella persona non è più e solo incapace di procurarsi una rispondenza adeguata, ma ha trovato un ascolto inadeguato che le viene garantito essere proprio quello giusto per lei. Da questo equivoco inizia la costruzione della sua identità come risposta consona alle premesse culturali.
Se non si immaginano alternative non resta che dire tutto il bene possibile di quello che c’è e che serve da commutatore di situazioni intollerabili in situazioni tollerabili. Tollerabili perché rispondenti a una cultura che con i suoi dogmi si imprime quale principio di autorità nella massa fluida di un essere e la solidifica. Ma quando l’alternativa viene intuita e sperimentata, allora l’adozione dello status quo culturale non ha più ragione di essere.
Perché l’autocoscienza è stata fraintesa e abbandonata in molti gruppi che dicono di averla fatta senza averla fatta? Perché si è considerato un passo avanti averla sostituita con la pratica dell’inconscio? Perché nella cultura maschile e nei suoi derivati al femminile nessuno capisce niente dell’espressione di sé in quanto tale.
In questi anni nel femminismo si sono ascoltati e detti fiumi di parole: chi sapeva come metterci le mani? Si passava dall’entusiasmo allo sconforto, dal tutto chiaro al tutto confuso. Finché è parso una salvezza l’intervento dell’interpretazione psicanalitica, non come assunzione di dottrina, ma come ricerca di una « nostra » dottrina. Ho sempre notato che le cose cominciano a andare storte non su gesti clamorosi di abdicazione, ma su proposte costruttive.
Occorrevano un ascolto diverso (rispondenza) e una parola diversa per un dialogo effettivo, quello di cui tutte avvertivamo la mancanza. Bastava non buttare a mare le premesse, non essere prese dall’urgenza di presentare un bilancio. Soprattutto bastava neutralizzare il momento culturale, quello non espressivo, additarlo, analizzarlo, screditarlo, sradicarlo dalla terra grassa dell’approvazione maschile.
Molte avevano perso la naturalezza a esprimersi, le più acculturate certamente, e sembravano non poterla ritrovare (di questo ci siamo accorte con spavento nei gruppi); per loro la pratica dell’inconscio rappresentava una tentazione, ma per le altre non coscienti di un’espressione che costituiva il loro filo di Arianna, perché indirizzarle dove si prende in considerazione la parola viva come se fosse morta? Nei gruppi si è instaurata una sordità all’espressione, sordità dovuta appunto a un acculturamento ansioso di diventare operante.
E questo chiamo autocoscienza: fare in modo che chi parla prenda coscienza che trovare se stesso è riconoscersi nell’espressione di sé, che non esiste verità al di fuori nell’adesione o nell’uso di chiavi interpretative. Certo non è facile, spesso è disperante, ma chi ha detto che sarebbe stato facile e non disperante?
Se io ho vissuto tensioni dolorose e smarrimenti non è stato perché non sapevo che la Madre mi ha tradito, ma perché le donne continuavano a farlo, nella stessa incoscienza e mimetizzazione, cosicché non trovavo un’eco adeguata e perdevo fiducia al punto che avrei potuto rinunciare a me stessa. Non ci ho rinunciato, non sono impazzita. E non ci ho rinunciato perché non ho smesso di cercare chi potesse darmi risonanza e non mi sono scoraggiata quando mi sono accorta che la risonanza era parziale perché ho tentato di imbastire relazioni che la implicassero sempre di più.
Lo strazio del caso di Dora non è tanto nella inadeguatezza di Freud a interpretarla (ogni interpretazione soddisfa chi la fa non chi ne è l’oggetto), quanto nel fatto che non ci fosse un altro tipo di ascolto e di colloquio per la povera Dora che quello con qualcuno che l’avrebbe interpretata ricavandone teorie. E’ quell’altro tipo di ascolto che ancora non siamo riuscite a tirare fuori dal femminismo, eppure è lì, è raggiunto. Come ognuna di noi, Dora vuole esprimere un complesso di emozioni e di interrogativi, accertarsi se è legittimo provare quello che lei prova e di cui sembra non ci sia traccia nel creato. La mancanta rispondenza produce su chi la subisce l’effetto di non esistere, di essere un errore vivente, e si configura come Domanda a cui necessita una Risposta. Proporsi come Risposta a chi non può che formulare la Domanda, non fa che mantenere in quella incoscienza di sé che si manifesta appunto nello schema di questo rapporto.
Nel femminismo esiste l’aspettativa di una Risposta, e l’invocazione continua a una teoria che eviti il ristagno non fa che richiederla per via indiretta, mentre io vedo che solo la demolizione di tale aspettativa può liberare energie inferiorizzate (non coscienti) che restano inoperanti nel mondo femminile e dare spazio all’autocoscienza, cioè a quella presenza a se stesse momento per momento che cala nel presente e fa toccare la sostanza di sé. L’identità scaturisce da questa radicale rinuncia a una Domanda e perciò a una Risposta: frantuma la Domanda in una miriade di espressioni di coscienza che richiamano nel dialogo miriadi di rispondenze, la rispondenza (e non la Risposta) essendo l’effetto che l’espressione dell’altra coscienza produce su di me quando mi metto in contatto con lei.
Non è stata cosa da poco avere pronunciato la formula « talking cure » (« cura del parlare») da parte di Anna O., la paziente di Breuer: lui andava e la ragazza parlava. Dopo avere parlato stava meglio, ma era quello l’ascolto per il quale la ragazza parlava? Senza sapere di proseguire sulla strada da lei indicata, noi abbiamo cominciato a scrivere e pubblicare le nostre autocoscienze. Il parlare soltanto è troppo aleatorio, non resta traccia di niente, né di quello che si è detto, né di quello che si è ascoltato: le mediazioni hanno buon gioco a interferire.
I rapporti con donne e la parola personale scritta rappresentano la condizione diversa dal passato, forse decisiva, per dare uno sbocco a quelle donne che vedono nell’autonomia dalla cultura la possibilità di impostare relazioni, dialoghi e espressioni di sé.
Le disparità tra gli esseri dipendono da disparità di riconoscimento e di ascolto. Ci si inferiorizza, si sparisce se non si trova spazio per il proprio essere e la sua manifestazione. La disparità dell’incontro psicanalitico, anche nelle sue forme selvagge nel femminismo, sta in questo: che la analizzante può contare su una cultura che la riconosce nelle sue teorizzazioni, mentre l’analizzata non può contare su una cultura che la riconosca nella sua espressione. E’ quest’ultima che deve fare il passaggio sul terreno altrui.
Dialogo. Cos’è oggi il nostro gruppo? È un gruppo di donne che scoprono il vero motivo per stare insieme quando tutti i motivi ideologici, che pure sono serviti da richiamo all’inizio, sono caduti. Altre donne via via si sono allontanate. Quelle che restano senza avere più alcuna ragione per farlo se non il desiderio e l’intenzione di farlo, quelle costituiscono il gruppo.
Questo vive della sua stessa vita, cioè vive dei rapporti che riesce a sviluppare, delle crisi dei rapporti, delle riprese e dei chiarimenti, vive di tutto ciò che arriva a mettere ciascuna di fronte a se stessa e alle altre.
Se c’è un ambito dove la vita somiglia di più a me stessa, mi è più congeniale, risponde di più a quello per cui sono e mi sento idonea questo è il gruppo. E mi sento idonea non perché è un angolo protetto e selezionato di incontri, ma al contrario perché posso dare agli incontri tutta l’ampiezza, l’avventurosità e l’evoluzione che né la mia vita privata né quella pubblica, entrambe strutturate e rese previste dai ruoli, mi hanno permesso di sperimentare come mio apporto.
La coscienza di me come soggetto politico nasce dal gruppo, dalla realtà che ha potuto prendere un’esperienza collettiva non ideologica. Essere riuscite a fare esistere questo tipo di gruppo ci ha dato la misura della nostra capacità di uscire fuori dalle strutture e dagli schemi maschili, di liberarci dal loro potere di oppressione, di cominciare a esistere per quello che siamo. Non è che un passo, ma di natura politica. Ci ha fatto capire cos’è stare insieme potenziando l’essere se stessi invece che tradirsi, ci ha permesso di vivere un senso di completezza che storicamente ci mancava come creature perennemente gregarie.
Quando si dice che la politica è finita si allude al fatto che è finita la fiducia in una concezione ideologica dell’essere umano al quale la Politica si rivolgeva e per il quale prospettava sia la restaurazione sia la rivoluzione. Già nel primo Manifesto c’eravamo pronunciate contro l’ideologia e nei primi anni di gruppo ci siamo dibattute per smaltire quei residui che ci portavamo addosso pur non volendo. Ci siamo affidate al dialogo.
Così ci siamo accorte che il passaggio da una concezione ideologica a una non ideologica della società si arresta proprio nel caos indistinto che il parlare provoca non essendo più sorretto dal modello ideale attraverso il quale gli individui si pongono in contatto gli uni con gli altri indirizzandosi a mete comuni. Appena c’è ordine c’è accordo sui valori, quando questo salta subentra la disgregazione.
E’ in questo preciso momento che un gruppo come il nostro si forma e va avanti, non perché abbia delle proposte, ma perché recupera e porta alla coscienza una fiducia nel dialogo che fa parte del passato femminile e che è sempre stato schiacciato dalla onnipresenza di certezze ideologiche. Che il femminismo non si accorga di questo suo ambito di attuazione e venda, per quattro soldi di approvazione a livello strumentale, la sua idoneità nel punto di svolta, mi sembra la beffa più colossale che una cultura e una politica siano mai riuscite a organizzare ai danni degli oppressi.
Detto questo, non so cosa può capitare al gruppo e a me che ne faccio parte. Ho ancora la tendenza a garantirlo davanti a me stessa, ma è solo una cattiva abitudine. In effetti non posso affermare niente. Quando all’inizio scrivevo « Il problema femminile… non va diretto né organizzato, né diffuso né propagandato », avevo di mira la salvaguardia di uno stato di autenticità fra le donne che è stato frainteso come spontaneismo politico, e adesso ne subisce la sorte. I richiami all’organizzazione che si sentono sempre più insistenti nel femminismo sono segnali di stanchezza di un movimento sviato dall’ambizione di dimostrare il suo peso sul vecchio terreno politico e di dimenticare le origini, non lontane nel tempo, ma lontanissime ormai dallo spirito delle prospettive a cui si sente allettato.
Se i rapporti hanno una loro verità che non può essere sorretta dall’esterno senza essere snaturata, perché dovrei rifiutarmi di accettarla? Un tempo il timore di una rottura con un’amica, una del gruppo mi angosciava. Ci vedevo un fallimento di qualche premessa, il fallimento di un ideale che avevo sovrapposto al rapporto, e a cui tenevo. Adesso ho acquistato una serenità prima sconosciuta: questo è dovuto al fatto che a una incomunicabilità sopraggiunta non corrisponde più alcun noblesse oblige che avrebbe voluto io la superassi a tutti i costi, avendo capito che anche le incomprensioni sono preziose, anche le rotture quando se ne coglie l’inevitabilità. Il problema per me – l’ho acquisito col tempo – non è mantenere in piedi il plenum dei rapporti, ma accettare di distaccarmi da un rapporto quando la mia volontà che duri possa costituire un impedimento alla chiarificazione reciproca.
I rapporti si sganciano via via dai modelli familiari sui quali l’esperienza precedente li richiamava orientandoli su strade senza uscita. Infatti nel rapporto familiare la pretesa o l’obbligo o la garanzia del non-scioglimento vengono attribuiti all’altro in modo da potere passare il limite senza accorgersi di rischiare, fidando in un sottinteso ricatto. Invece nel gruppo si rischia, non è un nucleo indissolubile di consanguinei, e è da questo rischio che scaturisce il proprio senso di responsabilità verso se stessa e verso le altre. Nel gruppo l’immunità e il circolo vizioso della famiglia si spezzano dando luogo a situazioni individuali a cui non è concessa la scappatoia di colpevolizzare il gruppo (istituzione), dato che ciò che lo fa esistere è che nessuna lo desideri al di là di quello che è. E il gruppo « è » disgregabile.
Tuttavia il piacere della scoperta si è introdotto come dato cosciente nei nostri rapporti insieme ai contenuti degli stessi, cosicché riesce sempre più a bilanciare e a portare all’attivo gli andamenti di un qualcosa che per definizione sfugge al controllo. Anche se , per mantenere l’equilibrio in una situazione così instabile, è indubbio che concorrono fattori legati al quadro più vasto della propria vita e alle soddisfazioniche si riescono a ottenere su altri fronti, però soddisfazioni sempre di una natura analoga. Altrimenti nel gruppo finirebbero per confluire richieste di sbocco personale che il gruppo non può dare senza diventare un sostituto di soluzioni che stanno altrove. Nel gruppo si prende coscienza del proprio vivere e del proprio pensare, si concentrano le spinte a vivere e a pensare che nella vita personale si erano fermate. Da lì ripartono per forzare quell’arresto. E lì tornano con la carica vitale dell’arresto forzato.
I rapporti nel gruppo costituiscono una realtà nuova, fuori dalle possibilità di essere manipolata.
Al contrario il femminismo come tematica ha già dato luogo a un fenomeno di massificazione: in quasi dieci anni di vita si è andato sempre più uniformando a ciò che del femminismo capiscono gli uomini, li mette in crisi, li fa rilasciare interviste, scrivere libri, articoli, fare film, dibattere e discutere. E’ diventato la comica di se stesso: si è lasciato rubare le parole di bocca per poi andare a ascoltarle e ripeterle nella confezione ufficiale dei problemi. Lo slogan tanto celebrato che lo riassume, « il privato è politico », può dare la misura riduttiva a cui si è adeguato nel diventare tematica: si riconosce il traguardo (politico) del femminismo nella denuncia dei ruoli (privato) e si aspetta che tiri le conseguenze, « che fare? »