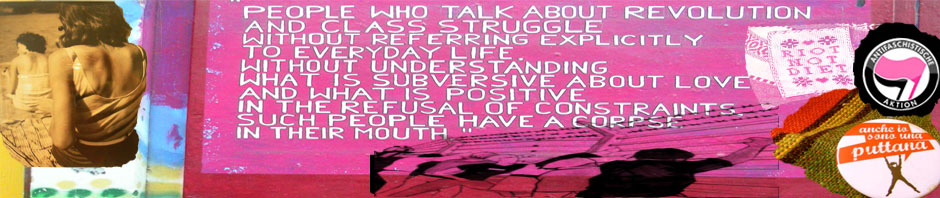Skip to content
In mauritania e altrove. Immagini sospese, e una riflessione sulla schiavitù
Arrivati a Saint-Louis, finiamo a cena con due giovani sociologi della seconda università senegalese. L’appuntamento era venuto fuori per una delle tante reti di persone in relazione, se non anche complicità, che ci rendono l’europa e il mondo intero un crocevia di rimandi, coincidenze e preconoscenze. Il mio compagno di viaggio inizia a raccontar loro della discesa a sud che ci aveva portato lì, seduti con loro al tavolo di quel bar in riva al fiume senegal. In particolare di come il passaggio per la mauritania gli e ci abbia lasciato sensazioni e domande sospese. Prima su tutte la questione della schiavitù. Emersa non solo perchè anche la guideroutard, nel suo fastidiosamente.democratico capitoletto – mauritania et droits de l’homme- ne parlava. Ma perchè, camminando in giro, in qualche modo una forma di segregazione ci sembrava palese.
Ce l’avevamo davanti agli occhi l’assenza dei e delle noirs nello spazio pubblico (in particolare nei luoghi “di consumo”), se non in certi posti di lavoro: ad affumicare i pesci, a vender verdure al mercato, sulle piroghe, nelle officine meccaniche, come inservienti nelle boutique.. . Il semplice acquisto di una bottiglia d’acqua, diceva il mio amico, sembrava racchiudere tutto: la bottiglia raccattata dal fondo di un frigorifero dal “dipendente/schiavo” negro, che però non aveva accettato il denaro perché il mauritano proprietario, con il suo raffinato abito bianco.oro.celeste, era l’unico ad avere il diritto di toccar i soldi. Io restavo con i miei dubbi antropologggici inespressi sul se quella segregazione di fatto razziale che avevo visto in giro fosse chiamabile schiavitù. Anche il caso della boutique… che differenza c’era con gli apprentis visti in Senegal, che lavorano come dipendenti nei laboratori artigianali, in cambio, quando va bene, del costo del biglietto dell’autobus per recarsi al lavoro? Loro sono alle dipendenze dei “mastri-artigiani”, fanno il lavoro “sporco” e anche loro non toccano un franco. Non sapevo e non so ancora distinguere sulla base di quel poco che ho visto. Anche l’immagine scorsa in macchina, appena passata la nomansland, al bivio tra Nouackhott e Nouadhibou.. quando abbiamo visto dal finestrino scendere dal cassone del camion una ventina di uomini africani e incamminarsi in mezzo alla sabbia e al vento. Era una sorta di cantiere, e ci è stato detto che probabilmente quegli uomini erano maliani che stavano andando a lavorare. Nessun accenno in più eravamo riusciti a cogliere sulle condizioni di lavoro di quegli uomini; anche questo rimasto sospeso.
So invece che con il termine schiavitù dovrebbe essere indicato un rapporto sociale assai preciso, nonostante venga spesso a mio parere impropriamente usato come sinonimo di duro sfruttamento (tra cui anche er indicare le condizioni attuali di lavoro di uomini e donne africane in Europa). Schiavitù, la mia “disciplina” insegna (da Meillassoux a venir in giù), è la condizione di estraneità e di asservimento totale in cui si trova una persona che all’inizio è assolutamente straniera, che viene catturata e poi venduta. Ha a che fare con la guerra, e con le vicende politiche che hanno attraversato l’Africa subsahariana già prima della presenza europea nell’area, e che la tratta atlantica prima e il colonialismo dopo non hanno fatto che esacerbare. Schiava è così una persona ridotta in schiavitù, costretta a perdere ogni legame sociale che aveva e ritrovatasi a dipendere solo dal suo unico padrone, che ne è proprietario, che gli sottrae la discendenza e che può disporne come vuole. Questo, dicono un sacco di antropologi, è il rapporto di dipendenza personale più estremo.
E in Mauritania persiste. Anche se, appunto, non direi di averlo visto. Persiste perché solo nel 1981 la schiavitù è stata legalmente abolita. O meglio, il 5 luglio del 1980, in seguito ad una mobilitazione di discendenti di schiavi, costituenti il movimento El Hor, e alla dura repressione che ne era conseguita, il Comitato Militare di Salute Nazionale proclama l’abolizione della schiavitù. Questa abolizione viene sancita dal provvedimento del 9 novembre 1981, a cui però non segue alcun decreto attuativo (qua trovate un articolo che ripercorre in modo assai più dettagliato la storia dello stato mauritano indipendente in relazione allo schiavismo). Cito da un buon libro scritto da Fabio Viti, antropologo dell’università di modena, che si occupa principalmente di Costa d’Avorio, ma che fornisce analisi interessanti anche su tutta l’Africa Occidentale. L’ho ripreso in mano in questi giorni di ritorno, e avrei voluto farlo prima di partire. “in mauritania, l’ultimo stato ad aver abolito la schiavitù nei codici ma non negli usi, uno strato nobiliare arabo-berbero ( i Mauri o bidhan) è ancora in grado di tenere legati a sé, come clienti o servitori, gli ex-schiavi affrancati (haratin), che da soli costituiscono circa la metà della popolazione e formano un “complemento del sistema segmentario della società maura” (Ould Saleck, 2000, p. 262; Messaoud, 2000). Questi, a loro volta, sono separati dalla popolazione negro-africana (sudan), Soninké, Toucouleur, Peul Wolof, Bambara, anch’essa discriminata nella vita civile e politca ma che, a sua volta, possiede o possedeva i propri schiavi (Ruf, 2000; Kamara, 2000). Anche se gli status sociali non sempre coincidono con divari economici e talvolta gli ex padroni non sono più in grado di provvedere ai loro dipendenti, “le relazioni schiaviste non sono scomparse e fanno prova, al contrario, di una vivacità certa che si traduce in una capacità di adattamento sorprendente” (Ruf, 2000, p. 252). Così, mentre la schiavitù rimane un argomento tabù nelle sfere dirigenti, la discriminazione colpisce gli haratin nel possesso di terra, nel diritto ai proventi del proprio lavoro, nell’accesso all’istruzione e alla giustizia (Messaoud, 2000), grazie anche alla adozione della sharia come fonte unica del diritto (Ould Ahmed Salem, 2003); più banalmente, per le resistenze del clero musulmano e le interpretazioni restrittive del diritto musulmano malekita, in Mauritania è ancora oggi impensabile il matrimonio tra un (ex)schiavo e una donna di famiglia nobile (Botte, 2005).”
Per tornare a quella sera a Saint-Louis, è proprio di quest’ultimo aspetto, ovvero del ruolo della religione nel legittimare i rapporti sociali gerarchici e politico-istituzionali esistenti, che uno dei due sociologi strutturati in università ci parla, raccontandoci a sommi tratti della vicenda di Biram Dah Abeid, filosofo, haratin, presidente e fondatore nel 2008 dell’IRA, Iniziativa per la Risorgenza del Movimento Abolizionista (IRA che Biram crea dopo che la precedente realtà in cui faceva attivismo, l’associazione SOSEsclavage, lo aveva ritenuto troppo radicale). Qua trovate un’intervista in italiano, in cui Biram così spiega: “dopo l’indipendenza della Mauritania nel 1960, queste stesse élite arabo-berbere hanno ereditato lo Stato post-coloniale dalla Francia, nascondendo e conservando la schiavitù, nonostante la promulgazione di costituzioni e leggi in teoria egualitarie e la ratifica di molte convenzioni, per ingannare la comunità internazionale. Nel 1981 la schiavitù è stata abolita, senza però che fosse criminalizzata o sanzionata, e l’art. 2 di questa legge di abolizione (il cui decreto applicativo non è stato mai varato) recita: “Lo Stato risarcirà gli aventi diritto”, aventi diritto che altri non sono se non i padroni degli schiavi, ai quali si è promesso una contropartita per l’abolizione. Dunque questa abolizione paradossalmente è stata un riconoscimento de facto e de iure della legittimità e della sacralità della schiavitù in Mauritania. Così i padroni hanno continuato bellamente a tenere sequestrata una numerosa popolazione servile, reclamando crediti verso lo Stato, alla luce di questa abolizione che si è trasformata in ordinanza di sequestro degli schiavi. Nel 2007, il primo presidente democraticamente eletto in Mauritania ha fatto votare una legge che criminalizza la schiavitù e le pratiche schiaviste. (…) tuttavia non è stata avviata alcuna inchiesta o procedimento penale, ciò che vuol dire che la legge è sempre lettera morta, perché sono i membri dei gruppi favorevoli alla schiavitù che dominano la giustizia, l’amministrazione, l’esercito, la diplomazia, la stampa ed il governo…. (…) La situazione in Mauritania è molto critica: c’è una minoranza etnica e di classe, gli arabo-berberi, che detengono le leve del potere politico, economico e militare del paese a detrimento dei cittadini considerati di seconda categoria, vale a dire le etnie nere (Pulaar, Soninke, Wolof, Barbara), e di quelli considerati ancora più inferiori, come gli haratine (schiavi ed ex schiavi). I neri sono stati vittime di razzismo, di sparizioni forzate, di deportazioni, di estorsioni extra-giudiziarie, di espropriazioni e di allontanamenti massicci dagli impieghi pubblici e privati. Gli orfani, le vedove, i licenziati, i deportati, gli espropriati non hanno ancora ottenuto nemmeno un’ombra di verità, giustizia e riparazione, perché gli istigatori di questo genocidio, tranne l’ex dittatore Maawuya Ould Sidi Ahmed Taya, sono ancora al comando del paese. Quanto ai numerosi schiavi ed ex schiavi, poveri ed impoveriti, essi continuano a subire impunemente le pratiche schiaviste ed ancestrali con tutto ciò che queste comportano, come il lavoro non remunerato, analfabetismo, pene corporali, violenze sessuali, espropriazioni terriere… ecc… Quelli che vivono in campagna sono confinati in specie di homeland (i territori assegnati ai neri nel Sudafrica dell’apartheid, ndt), privi del minimo necessario per una vita decorosa; quelli poi che sono scappati nelle città, si ammassano in ghetti intorno alle grandi città, in condizioni di povertà e precarietà totale”.
Nel 2012 dei fatti si sono susseguiti in Mauritania nel giro di un mese. Ne informa un antropologo del Centre des Etudes Africains di Parigi. Il 26 marzo la corte suprema rimette prima del tempo in libertà ahmes ould hassine, che era stato condannato nel 2011 a 2 anni di carcere per schiavitù. L’unico, dal 2007, da quando era stata votata la legge, ad essere stato condannato per schiavitù in Mauritania: sfruttava come guardiani di capre due schiavi per nascita,Saïd Ould Salka di 13 anni e suo fratello Yarg Ould Salka, di 8. Il 14 aprile poi, Radio Mauritanie diffonde il sermone di un imam saudita, Saleh Ibn Awwad al-Maghamissi. Dalla Mecca, quest’uomo chiede ai Sauditi e agli altri musulmani del Golfo, come atto di carità, di andare in Mauritania a comprare gli schiavi e liberarli. Aggiunge che ogni persona sarebbe costata 10 000 riyals, circa 2000 euro. Il 27 aprile quindi, i militanti dell’IRA organizzano la preghiera del venerdì in piazza, in un quartiere popolare di Nouackhott. Come forma di protesta, Biram brucia alcuni testi giuridici della scuola islamica Malikita, in cui si legittima il rapporto di schiavitù; testi che sono quelli su cui si basa l’organizzazione della Repubblica Islamica della MAuritania. Il suo obiettivo era quello di nominare pubblicamente l’esistenza della schiavitù in mauritania e dire chiaro e tondo che la scuola malikita è solo una corrente interpretativa giuridica e storica, e che non è ciò che prevede la religione musulmana così come annunciata da Maometto. Tale gesto è stato mediaticamente usato dal governo mauritano per demonizzare Biram come un blasfemo che ha “violato i valori islamici del popolo mauritano” e attentato alla sicurezza dello Stato, incitando di fatto una manifestazione di massa che è scesa in strada richiedendo la messa a morte di Biram. Poi Biram è stato arrestato con un raid militare nella sua casa, assieme ad altri 10 militanti dell’IRA, e rinchiuso in prigione per alcuni mesi.
Qua trovate un reportage, realizzato qualche mese fa da parte di reporter occidentali. Raccontano dell’ultima iniziativa dell’IRA, l’aver accompagnato dall’ottobre 2013 con sit-in e pressione mediatica la denuncia di una giovane haratine di una regione interna del paese contro una famiglia di ricchi mauri che l’avrebbero tenuta in schiavitù dalla sua infanzia. Biram avrebbe così detto «Non si può lottare contro la schiavitù chiusi in un ufficio. Ci vogliono delle azioni per spostare le linee del potere. Ci vogliono sit-in, bisogna andare in prigione, farsi picchiare. Bisogna morire (…) l’IRA è un’organizzazione non violenta. ma se le autorità cercano di farci fallire, altri, dopo di noi, useranno violenza per esigere giustizia. la sola strada, per loro, sarà la lotta armata». L’operato dell’Ira sarebbe criticato da un’altra parte del movimento mauritano anti-schiavismo. La presidente dell’associazione di donne capo famiglia, sostiene che l’Ira “tira fuori gli schiavi dall’ambiente in cui hanno sempre vissuto, crea un grande casino con loro, poi li abbandona. se le vittime non sono prese in carico, finiranno per tornare dai loro padroni in mancanza di altro”. Il governo mauritano gioca sul fatto che in generale il movimento anti-schiavista è organizzato in associazioni e ricerca l’attenzione mediatica, se non finanziaria, dei paesi “occidentali”.
Isabelle Hachey poi, in quel reportage aggiunge: “Non eran passate due ore dal nostro arrivo a Nouackchott che tre poliziotti sono arrivati senza preavviso al nostro albergo. volevano saperne di più sul nostro progetto di reportage. erano cortesi, quasi troppo gioviali. “Benvenuti in Mauritania, benvenuti in mauritania” ripetevano senza fine. Non eravamo rassicurati. Gli abbiamo spiegato che La Presse Affaires preparava un grand reportage sull’imprenditoria nel mondo, cosa che non era falsa. Ma non era tutta la verità. Non abbiamo nominato la schiavitù. Il soggetto tabu rovina l’immagine della Mauritania. Sapevamo che i giornalisti che dichiarano di ricercare su questa pratica si vedono rifiutare il visto di entrata. Soddisfatti delle nostre risposte, i tre poliziotti sono partiti augurandoci un buon soggiorno”.
Questo mi fa tornare anche sull’esperienza con il poliziotto mauritano, che mentre cercavamo di arrivare a piedi alla punta di nouadhibou, in borghese, col suo vestito azzurro.bianco.oro, ci ha fermato e, mostrato il suo tesserino, ci ha chiesto di salire sulla sua punto e riportati al primo posto di polizia, quello al porto. Qui un suo collega in servizio ci ha controllato i visti sul passaporto e, rassicurato, ci ha offerto una pacata e limitata gita ad un dock del porto, probabilmente come forma di compensazione alla libera mobilità che ci era stata sottratta. E qui, sul momento, la mia reazione era stata di sentirmi per la prima volta veramente bianca, toubab; in qualche modo con una forma assoluta di privilegio in mano solo per il mio essere una bianca europea. Che il mio corpo e la mia incolumità davvero contassero a prescindere, e fossero di serie A. (Nel 2007 in Mauritania una famiglia di 4 francesi è stata uccisa, l’attacco rivendicato da Al-Qaeda, nel 2009 tre spagnoli e poi due italiani sono stati rapiti sulla strada tra Nouadhibou e Nouackhott.. Da allora il settore turistico, che vedeva europei venire in Mauritania per il deserto e alcuni importanti centri archeologici, è entrato in crisi, e da allora i turisti sono ipercontrollati e non possono muoversi in macchina la notte.) Però di fatto c’era anche altro in gioco… Ad esempio, nei trasporti collettivi che abbiamo preso, venivamo sempre controllati, fino a costituire un peso per chi si trovava con noi sul mezzo, visto che creavamo ritardo (e qui ci sarebbe da aprire una parentesi sui viaggi italia-francia con il bus e i controlli alle frontiere..). E poi, al solito, se non eravamo in regola, chissà che succedeva.. visto che la domanda, ripetuta, che ci ha fatto subito il tizio in borghese quando ci ha fermato è stato “avete i visti?” (è anche vero che all’ambasciata mauritana di rabat, ho compilato un modulo dichiarando cose verosimili, e il visto mi è stato fatto, pagando, in due ore senza chiedermi alcun documento che certificasse quello che avevo scritto).
Comunque, se ho iniziato questo kilometrico post, era anche per dire due cose sulla schiavitù in Europa, sugli usi retorici che se ne fanno. (su quello che è successo, durante questo viaggio, a goréE, in Senegal, attorno al memoriale della tratta atlantica magari scriverò un’altra volta). Non sono ovviamente la sola, né tantomeno la prima, ad averci lavorato un po’ su su questo discorso (vedi Moulier-Boutang.. dalla schiavitù al lavoro salariato). Secondo me la persona che l’affronta in maniera più seria e convincente è Alain Morice (la cui intro “Travailleurs étrangers entre émancipation et servitude”, al libro anche da lui curato “De l’ouvrier immigré au travailleur sans papiers. Les étrangers dans la modernisation du salariat“, vi consiglio). In un articolo scritto nel 2005 sui Cahiers d’études africaines, Morice si pone il duplice obiettivo di portare uno “sguardo critico sugli usi della nozione di schiavitù applicata a diverse situazioni contemporanee di soggezione, sia nel loro lassismo concettuale che nella politica che sembra sottintedervi; tentare dall’altro lato d’interpretare le ragioni del successo della “schiavitù metaforica”, che chiamo così per opposizione alle diverse forme di schiavitù storica, e mostrarne i rischi”. Morice riporta tra uno degli esempi il caso dei lavoratori marocchini nel settore agricolo in Spagna, sotto il regime dei contratti stagionali proposti dall’OMI. Sono contratti annuali nomintivi, della durata massima di 8 mesi, che il “lavoratore” sottoscrive, e che permettono a 10-15.000 maghrebini di entrare sul territorio francese. La sua ricerca parla del settore agricolo in Provenza, con lavoratori provenienti dal marocco. Così Morice scrive “Le condizioni di assunzione e di lavoro annunciano la metafora della schiavitù: sollecitate attraverso intermediari o parenti, gli stagionali devono spesso pagare il loro “ticket di ingresso” nell’impiego agricolo francese, al punto anche di lavorare a volte per quasi nulla per il primo anno. Sotto serre surriscaldate e in vigne dove la raccolta è sottomessa a cadenza, in un ambiente soffocato da prodotti fitosanitari, l’attività di raccolta e così penibile e pericolosa, per una tariffa oraria uniformemente fissata all’indice 100 (“ma talmente superiore a quello che avrebbero al paese” (di origine, ndt)), che gli sfruttatori ammettono di non trovare manod’opera locale, vedendo nella disponibilità dei marocchini la prova che il sistema soddisfa tutte e due le parti. Una disponibilità in effetti senza altri limiti che quelli della resistenza fisica, di cui si usa e si abusa per fare compiere ore supplementari poco o non pagate. separati dai loro, i migranti non sono quasi desiderosi di raggiungere la promiscuità degli alloggi stretti e poco salubri dove, anche grazie al razzismo, si vedono accantonati lontano dalle agglomerazioni: si tratta di ammassarne il più possibile spendendo il meno possibile. Aggiungiamo che, nell’insieme, gli sfruttatori sono impietosi con tutti coloro che sono vittime di malattia, incidenti o di semplice usura fisica, questo a volte anche con la complicità attiva dei servizi di protezione sociale. Bisogna inoltre notare che un triplice diniego giuridico colpisce i titolari di contratti OMI, in quanto stanieri e stagionali: primo, titolari di autorizzazione provvisoria di lavoro non hanno diritto al soggiorno permanente (..), secondo, reclutati su contratti a durata determinanta a carattere stagionale perdono anche i benefici relativi (..) e la possibilità di convertire il CDD in contratto a durata indeterminata; terzo, in quanto designati dal loro datore di lavoro durante la conegna del contratto all’OIM, dipendono dal potere discrezionale che costui ha di rinnovare o meno per la stagione seguente e non sono liberi di lasciare questo datore di lavoro per un altro senza il suo consenso (salvo lasciare la FRancia)”. Così Morice però aggiunge: “con il caso di questi salariati, di cui numerosi altri esempi equivalenti esistono nell’universo lavorativo alimentato a migranti, siamo al centro della schiavitù metaforica. Più efficace sugli animi che nella versione originale, più compatibile con gli usi formalmente liberali del rapporto salariato, questa “schiavitù”-qui ha sul suo omologo storico il vantaggio di presentarsi come un consenso, se non l’effetto di una volontà, dalla parte di colui che vi si sommette, ritenuto di fatto esserne il beneficiario. I datori di lavoro lo sanno, e non soltanto mettono questa inversione al servizio di una opportunista decolpabilizzazione, ma in più utilizzano l’adesione al sistema per perpetuare un individualismo propizio all’instaurazione di un divide et impera senza pietà nello sfruttamento – senza contare che i più zelanti avranno anche accesso al lucrativo status di intermediaro. Invece, di buon o malgrado, colui che si serve dell’adesione come leva della soggezione si deve comporre con la persona: ed è qui che si situa la rottura qualitativa tra la schiavitù metaforica e la schiavitù storica. Ecco ciò che spiega la vittoria del recrutamento nominativo sull’antica pratica dei lotti anonimi di lavoratori, conformemente – coloro che hanno i contratti OMI non smettono di ricordarlo – ai prinicipi del dritto civile che definisce il contratto tra persone”. Morice sostiene cioè che in gioco c’è un consenso, per quanto prodotto sotto paura, frutto della credenza nel sistema e che si dà sotto una costrizione che si alimenta di questa credenza. Si tratta di un sistema cioè, che al cittadino marocchino fa apparire una scelta praticamente obbligata l’entrare in questo contratto di sfruttamento; una scelta che resta però reversibile. La credenza nel fatto di non avere vie d’uscita, la credenza nella rarità dei contratti OIM e nel fatto che rappresentino un’opportunità fortunosa, viene alimentata in questo rapporto paternalista tra datore di lavoro e lavoratore; rapporto che è però paternalista e non schiavistico. Definirlo quindi come schiavistico, aggiungo insieme a lui, non permette di capire perché funzioni e si riproduca.
Parlare di schiavitù e soprattutto di tratta oggi, tra i migranti, permette di spostare il discorso dalla violenza e inumanità del sistema europeo di visti, alla criminalizzazione dei cosìdetti “trafficanti” (cosa inaugurata dalla UE con la Convenzione di Palermo nel 2000 in cui appunto si parla di lotta anticriminale e difesa dei diritti umani per parlare di criminalizzazione e chiusura selettiva delle frontiere). Parlare di schiavismo colpisce l’immaginario ma non permette di comprendere il sistema in cui tali rapporti di sfruttamento razzializzato si costituiscono. I passeurs diventano così trafficanti, e si distoglie lo sguardo dal perchè i passeur si presentano come figure indispensabili e ricercate. La tratta e la supposta “schiavitù” non è una sopravvivenza di arcaicità che andrebbe debellata, e che viene agita solo da altri “barbari”: la camorra o gli africani. Quello è un sistema gerarchico di rapporti sociali, non schiavistici, che approfitta e specula sull’impossibilità di movimento imposta dalla UE e dall’Italia ad alcuni, precisi, abitant* del pianeta. Questo discorso sulla tratta, sulla lotta all’illegalità del sistema di sfruttamento, nominato opportunisticamente “schiavismo”, lo fa l’OIL, la UE, gli “illuminati” del PD. E questi ultimi lo stanno facendo anche ora, a difendere la ragionevolezza del sistema mare nostrum (quando viene fuori che dal 2000, 23.000 persone sono morte in quel mediterraneo), a sostenere la ragionevolezza del dover dividere, prima ancora che arrivino, i rifugiati dai clandestini. Non devo insegnare niente a nessun*, ma c’è anche un altro aspetto che mi pone problema sul nominare la condizione di precarietà estrema come schiavitù. Soggettivamente mi preoccupano le mobilitazioni che si organizzano a partire da uno status rivendicato di vittima. E utilizzare oggi il registro dello schiavismo produce vittimilogia, e quindi inevitabili distinzioni, spostando il piano del discorso.